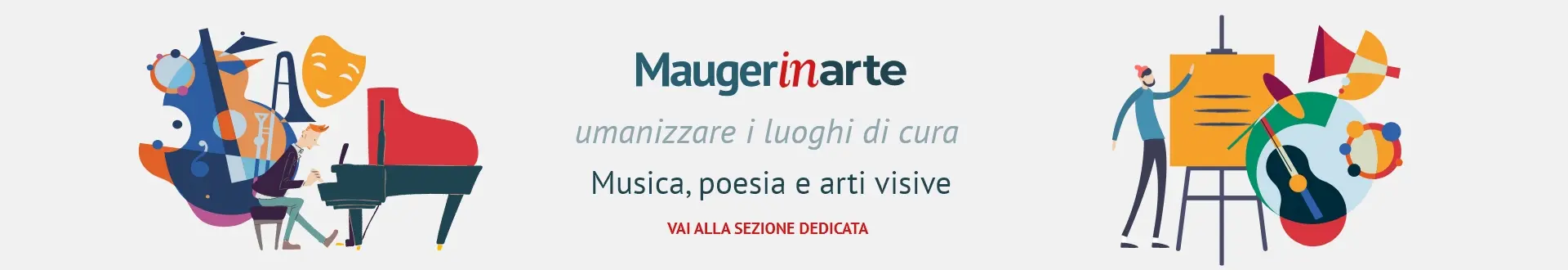Fascite
La fascite è un processo infiammatorio o un accrescimento anomalo che colpisce le fasce, strutture di tessuto connettivo fibroso che rivestono, collegano e sostengono i muscoli. Si tratta di una condizione eterogenea che può coinvolgere diverse parti del corpo e che include numerose varianti, distinte per cause, decorso e gravità. Alcune forme sono benigne e localizzate, altre potenzialmente gravi e sistemiche.
I sintomi variano notevolmente in base alla forma di fascite:
- Fascite plantare: dolore acuto o pungente localizzato nel tallone o nella pianta del piede, spesso più intenso al risveglio o dopo lunghi periodi in piedi.
- Fascite eosinofila: gonfiore e infiammazione della cute di braccia e gambe, fino all’indurimento degli arti e limitazione nei movimenti.
- Fascite necrotizzante: dolore improvviso e gonfiore, con febbre alta, vesciche, arrossamento, vomito, diarrea. Nei casi gravi può comparire necrosi dei tessuti e shock settico.
- Fascite monocitica: febbre ricorrente e infiammazione cronica, correlata alla rara sindrome TRAPS.
- Fascite nodulare: massa a crescita rapida in sedi superficiali, soprattutto estremità, tronco e collo.
- Fascite proliferativa e pseudosarcomatosa: forme benigne ma a rapida espansione, talvolta clinicamente simili a un tumore.
- Fascite retroperitoneale: dolori addominali e lombari, disturbi urinari, alterazioni vascolari locali.
- Fascite tibiale (periostite): dolore nella parte mediale della tibia, tipico dei giovani podisti.
Le cause variano in funzione del tipo di fascite:
- Fascite plantare: sovraccarico funzionale, postura errata, calzature inadeguate, piedi piatti o cavi, obesità, sedentarietà.
- Fascite eosinofila: eziologia sconosciuta, ma verosimilmente autoimmune o correlata a malattie del tessuto connettivo.
- Fascite necrotizzante: infezione batterica, spesso da più agenti, che si diffonde rapidamente nei tessuti molli.
- Fascite monocitica: legata alla sindrome TRAPS, malattia genetica autoinfiammatoria rara.
- Altre forme: possono derivare da proliferazioni benigne dei tessuti molli o da processi infiammatori cronici e localizzati.
La diagnosi della fascite si basa su una valutazione clinica e, a seconda dei casi, su esami strumentali e laboratoristici:
- Risonanza magnetica (RM): utile per documentare l’infiammazione o l’accorciamento delle fasce, soprattutto nella fascite plantare.
- Analisi del sangue: fondamentali nella fascite eosinofila (eosinofilia), nelle forme infettive e in quelle sistemiche.
- Biopsia muscolare: per confermare la diagnosi in casi selezionati, in particolare nella fascite eosinofila.
- Esami microbiologici: in caso di sospetta fascite necrotizzante, prelievi di pus e sangue sono essenziali per identificare il patogeno.
Il trattamento della fascite è specifico per ciascuna variante:
- Fascite plantare: riposo, FANS, massaggi, stretching del polpaccio, uso di plantari o tutori. In casi persistenti, terapia ad onde d’urto o chirurgia.
- Fascite eosinofila: FANS associati a corticosteroidi e bloccanti dei recettori H2 dell’istamina.
- Fascite necrotizzante: antibiotici ad ampio spettro e, nei casi più gravi, intervento chirurgico per rimozione del tessuto infetto o amputazione.
- Altre forme: gestione variabile, da osservazione clinica a trattamenti chirurgici nei casi proliferativi benigni rapidamente evolutivi.
Le informazioni presenti nel sito, validate dai nostri medici, sono destinate a scopi informativi/divulgativi e non sostituiscono in nessun modo il rapporto diretto medico-paziente, né la visita specialistica. È fondamentale sempre consultare il medico per una diagnosi precisa e trattamento personalizzato.
Ultimo aggiornamento: 16/06/2025
Istituti che accertano questa patologia
IRCCS Maugeri Pavia
via Salvatore Maugeri, 10 - 27100 Pavia (PV) Dermatologia Terapia del dolore Poliambulatorio Maugeri Milano - via Clefi
via Clefi, 9 - 20146 Milano (MI) Terapia del dolore Chirurgia plastica e ricostruttiva Dermatologia Patologie dalla A. alla Z.
- Patologie che iniziano con la lettera: A
- Patologie che iniziano con la lettera: B
- Patologie che iniziano con la lettera: C
- Patologie che iniziano con la lettera: D
- Patologie che iniziano con la lettera: E
- Patologie che iniziano con la lettera: F
- Patologie che iniziano con la lettera: G h
- Patologie che iniziano con la lettera: I j k
- Patologie che iniziano con la lettera: L
- Patologie che iniziano con la lettera: M
- Patologie che iniziano con la lettera: N
- Patologie che iniziano con la lettera: O
- Patologie che iniziano con la lettera: P q
- Patologie che iniziano con la lettera: R
- Patologie che iniziano con la lettera: S
- Patologie che iniziano con la lettera: T
- Patologie che iniziano con la lettera: U
- Patologie che iniziano con la lettera: V w x y z