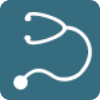Un importante lavoro di ricerca degli endocrinologi dell’IRCCS Maugeri Pavia, guidati da Luca Chiovato, si è segnalato nei giorni scorsi sulla stampa scientifica.
Si tratta di un paper che mette a fuoco la cosiddetta “tempesta di citochine”, uno stato infiammatorio che caratterizza il Covid-19, e che la comunità scientifica ha inquadrato solo dopo la primissima focalizzazione soprattutto sui danni all’apparato respiratorio. I clinici pavesi, da anni impegnati proprio sul sistema delle chemochine in relazione al tumore della tiroide, hanno potuto mettere a frutto le loro competenze su questo versante degli effetti del SARS-Covid-2.
Lo studio, pubblicato da Elsevier, porta la firma di molti collaboratori di Chiovato, come Mario Rotondi, Francesca Coperchini, Laura Croce e Flavia Magri.
Alla giovane biologa Coperchini, prima autrice dello studio, Notizie Maugeri ha rivolto alcune domande.
Da qualche mese, fra i lavori scientifici che riguardano il Covid-19, si è cominciato a parlare della tempesta di citochine. Qual è il contributo del vostro lavoro?
Gli studi scientifici riguardanti il COVID-19 stanno aumentando in modo esponenziale dall’inizio della pandemia ed attualmente in letteratura sono presenti più di 77mila lavori. Il nostro ha avuto il merito di aver identificato, già nelle primissime fasi della pandemia, l’importanza della tempesta citochinica e del ruolo cruciale delle chemochine nel condizionare un diverso decorso di malattia. Questo è stato possibile grazie alla nostra lunga esperienza nello studio del sistema chemochina/chemochina recettore, che è da anni una linea di ricerca del Laboratorio per lo studio dei distruttori endocrini. Le competenze acquisite sul ruolo delle chemochine nelle tireopatie autoimmuni, nel tumore della tiroide e nello sviluppo di complicanze di alcune patologie neurologiche, sono risultate fondamentali per identificare alcuni dei meccanismi immunologici alla base dell’infezione da Sars-Cov-2.
Vale a dire?
Al momento della stesura, le evidenze scientifiche su Sars Cov2 erano ancora limitate, pertanto si è cercato di rivedere criticamente la letteratura sulle precedenti Sars e Mers, al fine di trasferire le conoscenze alla attuale pandemia. In particolare, in uno studio in collaborazione con ricercatori spagnoli, abbiamo evidenziato come la produzione di una particolare chemochina sia alla base del fenomeno dell’anosmia, uno dei sintomi peculiari del SARS-COV-2.
Come funziona esattamente questo stato infiammatorio che caratterizza alcuni casi?
Nei soggetti più gravi, il SARS-COV-2 elude le principali difese immunitarie causando una produzione “disregolata” di molecole pro-infiammatorie, che reclutano cellule immunitarie. In particolare, a livello polmonare, si scatena una produzione eccessiva di piccole molecole chiamate chemochine, le quali attirano cellule immunitarie infiltranti a livello del sito dell’infezione. Queste cellule iniziano a produrre una serie di altre molecole pro-infiammatorie chiamate citochine, le quali a loro volta stimolano la produzione di altre chemochine perpetuando così una sorta di circolo vizioso, il cui risultato è una sovra-produzione di molecole pro-infiammatorie e di cellule infiltranti al sito dell’infezione. Questo eccessivo stato infiammatorio è appunto la famosa “tempesta citochinica” di cui abbiamo sentito tanto parlare, la quale, dopo aver danneggiato estremamente le cellule polmonari, si diffonderà ad altri organi, conducendo infine a insufficienza multiorgano e nei casi più severi anche alla morte.
Il vostro articolo individua una serie di lavori scientifici che avevano descritto gli stessi processi in presenza di altri virus, come la MERS-Cov del 2013. Che cosa, delle passate esperienza, torna utile oggi?
Nostro lavoro c’è un capitolo intitolato “Lezioni da SARS e MERS”. In questo modo abbiamo voluto sottolineare come gli studi fatti sui virus che hanno scatenato le precedenti epidemie siano stati di grande aiuto per comprendere nel migliore dei modi la complessità del COVID-19, confrontando le analogie e le differenze. In particolare, dalle precedenti esperienze su SARS e MERS abbiamo appreso come il virus possa facilmente eludere il sistema immunitario “ingannando” le principali vie di difesa e inducendo questo eccessivo stato infiammatorio, a cui consegue la “tempesta citochinica”; è stato dimostrato che SARS-COV-2 si lega allo stesso recettore di SARS (ACE-2) entrando nelle cellule che infetta con un meccanismo molto simile; infine il confronto con gli studi precedenti ha consentito di pianificare le possibili strategie terapeutiche.
Leggi l'articolo QUI
a cura di Giampaolo Cerri